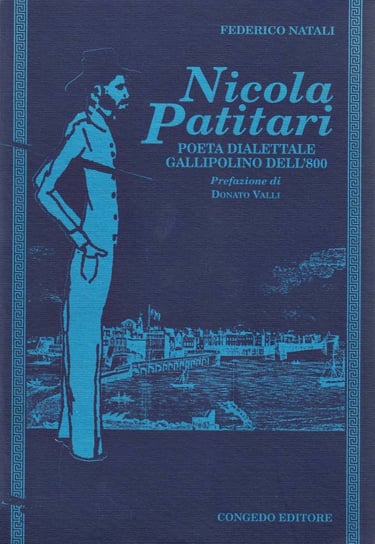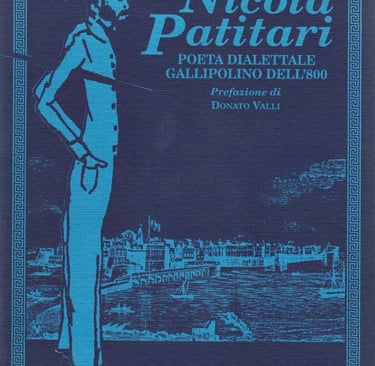La Mujere de lu piscatore
Na varca vedu a nu lontanu mare,
e nu la sacciu si è la vara tua;
lu core miu me vasa de dulore,
e l'occhi mi s'incanuscianu a chist'aria.
A chista aria de scuru e de burrasca,
e nu lu sacciu si te pozzu chiamare;
e si me senti, o mio piscatore,
ca lu mare se vasa ccu lu dulore.
Ah! Quista è la tempesta e li furtoni
ca s'hannu fattu d'ognunu lu luttone;
ah! ca te pregu, o Dio, ccu lu me core
nu me cagnare l'amore cu lu dulore.
L'onde sbattanu e lu sciuppu si sente,
lu sciuppu forte, e lu luttu è ccumminatu;
e l'occhi mi nu vidu lu mare,
ma l'anima mea è nu piscatore.
Lu piscadore meu sta ncanti a lu mare,
e nu lu pozzu cchiui 'ncunisci lu sule;
e lu sule si 'nguazza, e nu lu sacciu,
si lu piscatore meu è cu lu sole.